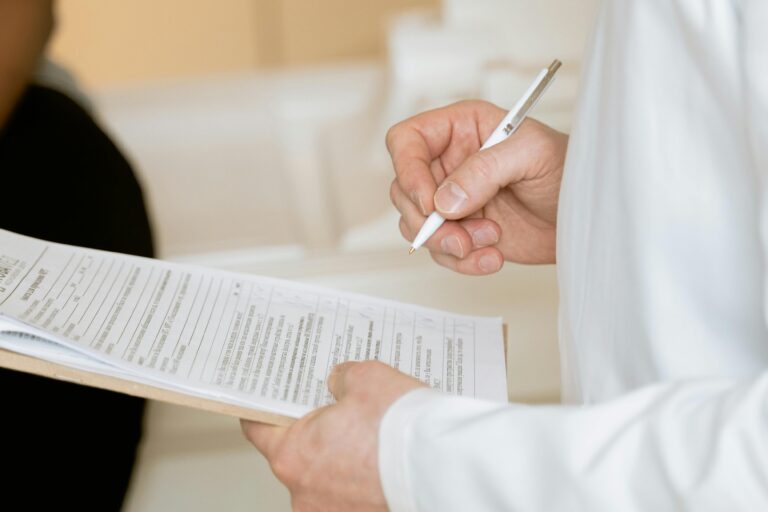Nella sentenza n. 18404 di oggi, 5 luglio 2024, la Suprema Corte compie un ulteriore passo avanti: in un rapporto di lavoro con uno studio professionale (successivo al “periodo di praticantato”), ai fini della subordinazione, non è più necessaria la prova, a carico del lavoratore, del concreto esercizio del potere direttivo (ordini e direttive), ma è sufficiente che ricorrano i seguenti “indici”: “postazione di lavoro all’interno dello studio professionale, assenza di clientela, orario di lavoro fisso, cura delle pratiche datoriali”. Della subordinazione classica, allora, rimane soltanto l’orario di lavoro fisso, anche se la sentenza non specifica se tale orario fosse stato imposto dal titolare dello studio. Dalla ricostruzione della motivazione della sentenza di appello si evince che la professionista curava “le pratiche affidatele dall’appellato (…) con orario di lavoro mattutino dal lunedì al venerdì e due pomeriggi a settimana”. Sembra, allora, ipotizzabile un accordo preventivo basato su una limitata disponibilità della professionista, la quale quindi non era andata oltre il mero rispetto dell’accordo iniziale.
Pertanto, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, gli unici dati certi sono l’assenza di una clientela propria e il fatto che la professionista curava “pratiche” del titolare dello studio e, cioè, curava interessi di clienti altrui. Tanto basterebbe per provare la subordinazione e, anzi, come afferma la sentenza, quella subordinazione “attenuata” che è “propria delle prestazioni intellettuali”.
Si tratta di una motivazione atecnica e relativa che, in omaggio ad una imprecisata attenuazione della nozione di subordinazione, porta a ritenere dipendenti tutti coloro che curano interessi di clienti altrui, come se l’elemento qualificante fosse la provenienza della clientela assistita (e non anche il modo in cui si lavora).
Non solo. La Suprema Corte aggiunge che, nel caso esaminato, la subordinazione attenuata sarebbe confermata “a contrario” anche dalla “assenza di elementi da cui desumere una collaborazione autonoma”, così finendo per porre a carico del convenuto l’onere di provare l’autonomia, con una inversione dell’onere probatorio non prevista dalla legge.